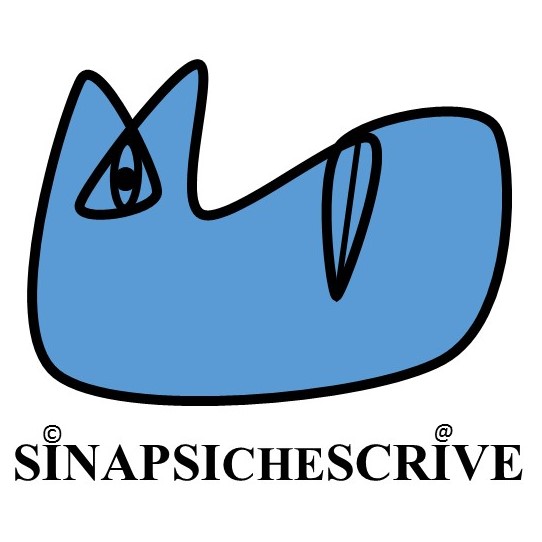Un volto dal passato
Franca Pichierri, agosto 2025

L’orologio del Municipio batté i tre quarti d’ora. Avevo quindici minuti per raccogliere le idee, prima dell’incontro fatidico. Il caffè non era dei migliori, sia nel senso di locale che di bevanda. Non avevo scelto io il posto: l’aveva fatto la donna che diceva di essere la mia madre biologica.
Mi ero messa ad un tavolo fuori, nella piazza semideserta e spazzata dalla bora che, indifferente alla mia stupidità, faceva null’altro che il suo dovere. Era novembre inoltrato. La fotografia d’epoca della pubblicità di un noto liquore della tradizione triestina campeggiava in vetrina. La modella che sorrideva ammiccante era mia zia. Parenti, parenti… oggi era proprio la giornatina dei parenti ritrovati. La parete a specchio della vetrina vicina mi rimandava l’immagine di una giovane, vetusta trentenne, con le occhiaie e niente luce nello sguardo. La canzone preferita della mia infanzia rimbombava nella mia mente, come per sgretolare anni di idea di famiglia perfetta, che mi si era frantumata solo una settimana prima. Un fulmine a ciel sereno aveva stravolto la mia vita.
La notizia mi era arrivata per posta, in forma di lettera. Chi mai scrive una lettera cartacea, nell’era di whatsapp e di Internet? Eppure. Era di un bel color crema, la carta, pesante. Uso mano, lavorata artigianalmente. Me ne intendo di carta, è il mio mestiere.
Quello che c’era scritto sopra, in una minuta ed esitante calligrafia, mi fece cadere dalla sedia.
Una donna, certa Carla Vattelapesca, mi diceva senza troppi preamboli che era la mia vera madre, costretta dall’età e dalla famiglia bigotta a lasciarmi alla nascita.
Si faceva viva appena adesso perché ci aveva messo anni per venire in possesso di dati censurati, tipo certificato di adozione, nome e indirizzo dei miei genitori adottivi, mia ultima destinazione di adozione.
Col sedere mezzo fuori dalla sedia e gli occhi sbarrati mi misi a riflettere. Il mio primo impulso fu quello di correre da mia madre, di sbatterle in faccia la lettera e la verità.
Mi pentii subito: la foga è la peggior consigliera; mio padre non stava affatto bene. Gli avevano trovato una massa sospetta in una radiografia del polmone. Sapevo che non prometteva niente di buono. Mia madre era l’ombra di se stessa, consumata dalla preoccupazione. Non potevo darle un altro problema, un altro macigno da portare. Avrei risolto da sola. Glielo avrei raccontato in futuro, o forse anche no. Dopotutto la vita era la mia e anche la “madre”. Avrei fatto da me.
Niente da dire, la puntualità era un suo pregio. Io avevo l’ossessione della puntualità. Che avessi preso da lei?
Una donna ancora giovane, ben vestita e di modi eleganti si presentò subito al mio tavolino.
“Oh, Paola, piccina mia… Ti avrei riconosciuto fra mille… Fatti guardare… Posso abbracciarti?”
Guardai storto quella bella donna.
“Il mio nome è Sara. Preferirei di no.”
“Oh, sì, scusa… scusami tanto… ti avevo chiamato Paola, alla nascita… ti ho potuto tenere in braccio solo mezz’ora, sai? Poi ti hanno portato via e non ti ho visto più.
Ma, dimmi, come stai? Sei felice? Hai avuto buoni genitori adottivi?”
Quel fiume di parole mi colpì al cervello e nell’anima, come una diga che crolla.
“Beh, sì, tutto sommato direi di sì. Ma lei… tu… non mi pare che te la passi male… perché mi hai abbandonata, allora!?”
Abbassò la testa, mortificata e confusa. Bene, avevo colpito nel segno. Volevo vendicarmi di lei, anche se era solo una figuretta esile di donnino: pesava sì e no quarantacinque chili.
“No, Pa… Sara, ti prego, non aggredirmi così. Voglio raccontarti tutto, voglio che tu capisca. Non pretendo che mi perdoni, ma che tu almeno comprenda… ti prego”
Ero intenerita, mio malgrado. Non lo avrei fatto notare neanche sotto tortura.
“Dimmi… su… racconta.”
Un po’ di colore apparve su quelle guance smunte, comunque impeccabilmente imbellettate.
“Oh, grazie, grazie, cara. Mi dai l’occasione di sdebitarmi del grave torto che ti ho fatto..”
Un singhiozzo le impedì di continuare. Tirò fuori dalla borsetta firmata un fazzolettino di batista di cotone, ricamato a sangallo. Era proprio una donna di altri tempi! Chi le aveva insegnato abitudini tanto obsolete, quanto affascinanti?
“Scusa, ora mi riprendo. Posso bere un sorso dal tuo bicchiere d’acqua?”
Un gesto così simil-familiare non le darà il diritto di avvicinarmi, pensai acida.
Bevve. Si appoggiò allo schienale scomodissimo della scomodissima seggiola di ferro battuto, tipicamente estiva e terribilmente fuori luogo, con la bora a cento all’ora e vari sentori di salsedine sulle labbra, frutto delle goccioline dal sapore amaro che signora Bora alzava dal mare astante il Molo Audace, poco lontano dalla piazza più grande e più bella d’Europa. Dove in quel momento stavo morendo di freddo e di curiosità, nell’ascoltare una storia che adesso non era più così importante scoprire. Mi bastava il gesto di quella donna: già la lettera e il fatto di averla mandata era un’ammissione di colpa. Ma bastava? Bastava veramente?
“…E, come ti dicevo, mi ritrovai incinta. Uno scandalo. La mia famiglia non era ricca ma ci teneva alle apparenze. E così…”
“…E così, dopo questo corso di belle arti in uno sperduto collegio svizzero, finanziato da una zia ricca, ancora più bigotta dei miei genitori, che guarda caso durò otto mesi, nascesti tu, bambina mia.
Comunque: tornai più tonica e magra di prima. Trovai già pronto il mio bel matrimonio combinato: i miei genitori mi fecero sposare l’avvocato di zia Angelina. Accettai. Mi avevano portato via l’anima nel momento in cui mi tolsero dalle braccia l’unica cosa che avessi mai sentito veramente mia, nella vita: tu, bambina mia”.
La guardai storto.
“…E basta? Secondo te, basta così? Secondo te questa è una giustificazione per lasciarsi mettere i piedi in testa dalla propria famiglia, prima, e dal maritino ricco, la seconda? E vivere tutta la vita una non-vita, come te, nella gabbia dorata dei tuoi rimorsi?
Io me ne vado. Anzi, visto che io compro i miei vestiti al mercato delle pulci e tu sei firmata dalla testa ai piedi, che vorresti fare? Darmi un po’ dei tuoi sporchi soldi? Sporchi di menzogna e accondiscendenza? Ma va’…. Vai… torna alla tua vita nella bambagia. Io tornerò alla mia vituccia, ma almeno sarò in pace con me stessa. Di te, dubito su questa cosa. Me ne vado. Addio” Feci per alzarmi, con tutta la dignità di cui fui capace.
Mi guardò, disperata, con quegli occhioni verdi da cerbiatta, così simili ai miei, nel suo visino smunto e melodrammatico.
“No, ti prego, Paola, ti prego… perdonami… potrai mai perdonarmi…?”
“Veramente, no.”
Ero già in piedi, imbacuccata nel mio giubbotto da pochi soldi.
“Ti auguro buona vita, Carla. Mi auguro che, adesso che hai dato un volto ai fantasmi del tuo passato, tu possa trovare un po’ di pace. Addio.”
Me ne andai per la mia strada.
Balzò dalla sediola, facendola cadere. Il soffiare dei refoli coprì il clangore del metallo.
“No… no… ti prego… ho fatto tanto, ho aspettato tanto per trovarti… e mi lasci così?!”
Piangeva, disperata, mi strattonava le maniche del giubbotto: si sarebbe gettata ai miei piedi, lo sapevo. Una scena penosa nel palcoscenico naturale più bello della mia bellissima città di adozione.
…” Ti prego, Paola, ti prego, piccina mia… te lo dice la tua mamma… ti prego…!”
Non resistetti. Ero un essere umano anch’io, dopotutto.
“Va bene, va bene. Vieni qui”.
Un unico, avvolgente abbraccio.
Fummo, per un momento, una cosa sola, come non fummo mai.
Cambiai idea: avrebbe fatto parte del mio futuro, decisi.
Ero disposta a provare.
Il viaggio dentro me stessa e al mio passato, svoltosi in una gelida mattinata di bora a Trieste, era giunto ad un nuovo punto di partenza: il resto della mia nuova vita. E, vicino, una persona desiderosa di essere solo una figura positiva per me.
Il Tempo avrebbe dato ragione o torto alle intenzioni. Optavo per il lieto fine, per una volta.
Immagine di ChatGPT