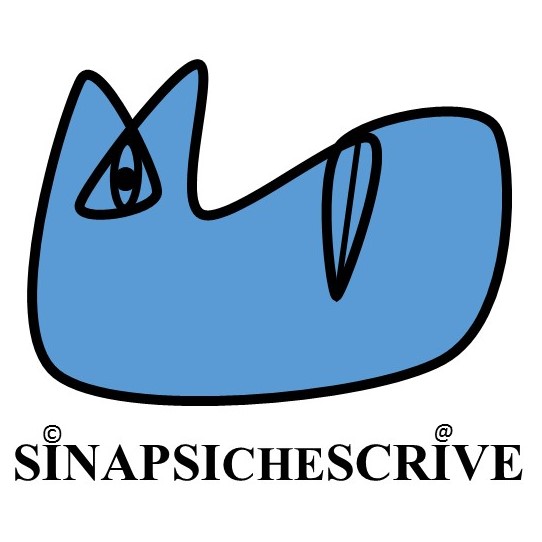Anche GRANDI autori hanno scritto
piccoli racconti.
Una storia al mese.

“Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto. Io sono orgoglioso di quelle che ho letto”
(Jorge Luis Borges)
Agosto 2024
Isaac Asimov
Luglio 2024
Giugno 2024
Maggio 2024
Aprile 2024
Marzo 2024
Febbraio 2024
Gennaio 2024
Dicembre 2023
Novembre 2023
Settembre 2023
Immagine di pch.vector</a> su Freepik
Settembre

aaaaaa
La morte dell’impiegato
di Antòn Cechov
Una magnifica sera un non meno magnifico usciere, Ivàn Dmitric’ Cerviakòv, era seduto nella seconda fila di poltrone e seguiva col binocolo “Le campane di Corneville”. Guardava e si sentiva al colmo della beatitudine. Ma a un tratto… Nei racconti spesso s’incontra questo “a un tratto”. Gli autori han ragione: la vita è così piena d’imprevisti! Ma a un tratto il suo viso fece una smorfia, gli occhi si stralunarono, il respiro gli si fermò… egli scostò dagli occhi il binocolo, si china e… eccì!!! Aveva starnutito, come vedete.
Starnutire non è vietato ad alcuno e in nessun posto. Starnutiscono i contadini, e i capi di polizia, e a volte perfino i consiglieri segreti. Tutti starnutiscono. Cerviakòv non si confuse per nulla, s’asciugò col fazzolettino e, da persona garbata, guardò intorno a sé: non aveva disturbato qualcuno col suo starnuto? Ma qui, sì, gli toccò confondersi. Vide che un vecchietto, seduto davanti a lui, nella prima fila di poltrone, stava asciugandosi accuratamente la calvizie e il collo col guanto e borbottava qualcosa. Nel vecchietto Cerviakòv riconobbe il generale civile Brizzalov, in servizio al dicastero delle comunicazioni.
«L’ho spruzzato!», pensò Cerviakòv. «Non è il mio superiore, è un estraneo, ma tuttavia è seccante. Bisogna scusarsi».
Cerviakòv tossì, si sporse col busto in avanti e bisbigliò all’orecchio del generale: – Scusate, eccellenza, vi ho spruzzato… io involontariamente…
- Non è nulla, non è nulla…
- Per amor di Dio, scusatemi. Io, vedete… non lo volevo!
- Ah, sedete, vi prego! Lasciatemi ascoltare!
Cerviakòv rimase impacciato, sorrise scioccamente e riprese a guardar la scena. Guardava, ma ormai beatitudine non ne sentiva più. Cominciò a tormentarlo l’inquietudine. Nell’intervallo egli s’avvicinò a Brizzalov, passeggiò un poco accanto a lui e, vinta la timidezza, mormorò:
- Vi ho spruzzato, eccellenza… Perdonate… Io, vedete… non che volessi…
- Ah, smettetela… Io ho già dimenticato, e voi ci tornate sempre su! – disse il generale e mosse con impazienza il labbro inferiore.
«Ha dimenticato, e intanto ha la malignità negli occhi», pensò Cerviakòv, gettando occhiate sospettose al generale. «Non vuol nemmeno parlare. Bisognerebbe spiegargli che non desideravo affatto… che questa è una legge di natura, se no penserà ch’io volessi sputare. Se non lo penserà adesso, lo penserà poi! …».
Giunto a casa, Cerviakòv riferì alla moglie il suo atto incivile. La moglie, come a lui parve, prese l’accaduto con troppa leggerezza; ella si spaventò soltanto, ma poi, quando apprese che Brizzalov era un “estraneo”, si tranquillò.
- Ma tuttavia passaci, scusati, – disse. – Penserà che tu non sappia comportarti in pubblico!
- Ecco, è proprio questo! Io mi sono scusato, ma lui in un certo modo strano… Una sola parola sensata non l’ha detta. E non c’era neppur tempo di discorrere.
Il giorno dopo Cerviakòv indossò la divisa di servizio nuova, si fece tagliare i capelli e andò da Brizzalov a spiegare… Entrato nella sala di ricevimento del generale, vide là numerosi postulanti, e in mezzo ai postulanti anche il generale in persona, che già aveva cominciato l’accettazione delle domande. Interrogati alcuni visitatori, il generale alzò gli occhi anche su Cerviakòv.
- Ieri, all’Arcadia, se rammentate, eccellenza, – prese a esporre l’usciere, – io starnutii e… involontariamente vi spruzzai… Scus…
- Che bazzecole… Dio sa che è! Voi che cosa desiderate? – si rivolse il generale al postulante successivo.
«Non vuol parlare!», pensò Cerviakav. impallidendo. È arrabbiato dunque… No, non posso lasciarla così… Gli spiegherò…».
Quando il generale finì di conversare con l’ultimo postulante e si diresse verso gli appartamenti interni, Cerviakòv fece un passo dietro a lui e prese a mormorare: – Eccellenza! Se oso incomodare vostra eccellenza, è precisamente per un senso, posso dire, di pentimento! …Non lo feci apposta, voi stesso lo sapete!
Il generale fece una faccia piagnucolosa e agitò la mano.
- Ma voi vi burlate semplicemente, egregio signore! – diss’egli, scomparendo dietro la porta.
«Che burla c’è mai qui?», pensò Cerviakòv. «Qui non c’è proprio nessuna burla! È generale, ma non può capire! Quand’è così, non starò più a scusarmi con questo fanfarone! Vada al diavolo! Gli scriverò una lettera e non ci andrò più! Com’è vero Dio, non ci andrò più!».
Così pensava Cerviakòv andando a casa. La lettera al generale non la scrisse. Pensò, pensò, ma in nessuna maniera poté concepir quella lettera. Gli toccò il giorno dopo andar in persona a spiegare.
- Ieri venni a incomodare vostra eccellenza, – si mise a borbottare, quando il generale alzò su di lui due occhi interrogativi, – non già per burlarmi, come vi piacque dire. Io mi scusavo perché, starnutendo, vi avevo spruzzato… e a burlarmi non pensavo nemmeno. Oserei io burlarmi? Se noi ci burlassimo, vorrebbe dire allora che non c’è più alcun rispetto… per le persone…
- Vattene! – garrì il generale, fattosi d’un tratto livido e tremante.
- Che cosa? – domandò con un bisbiglio Cerviakòv, venendo meno dallo sgomento.
- Vattene! – ripeté il generale, pestando i piedi.
Nel ventre di Cerviakòv qualcosa si lacerò. Senza veder nulla, senza udir nulla, egli indietreggiò verso la porta, uscì in strada e si trascinò via… Arrivato macchinalmente a casa, senza togliersi la divisa di servizio, si coricò sul divano e… morì.

Anton Pavlovič Čechov (1860-1904) è stato uno scrittore e drammaturgo russo, tra i maggiori autori letterari e teatrali europei del XIX secolo.
L’audio è realizzato da Audioraccontando (su Youtube)
Immagine di vecstock</a> su Freepik
Novembre

aaaaaa
Ombra
di Edgar Allan Poe
Voi che mi leggete siete ancora tra i viventi, ma io che scrivo, da molto, da molto tempo sarò partito per la regione delle ombre. Poiché, in verità, succederanno di ben strane cose, molti segreti saran rivelati, molti secoli passeranno prima che queste parole sian vedute dagli uomini. E quando le avranno vedute, gli uni non le crederanno, gli altri dubiteranno, e ben pochi troveranno materia di meditazione nei caratteri che su queste tavolette vo tracciando con uno stile di ferro.
L’anno era stato un anno di terrore, pieno di sentimenti più intensi del terrore, pei quali non c’è un nome sulla terra. Poiché c’erano stati molti prodigi e molti segni, e da tutte le parti, sulla terra e sul mare; le negre ali della Peste s’eran largamente spiegate. Ma quelli ch’eran sapienti nelle stelle non ignoravano che i cieli aveano un aspetto di sventura; e per me, tra gli altri, il greco Oinos, era evidente che stavamo al ricorso di quel settecentonovantaquattresimo anno, in cui, all’entrata in Ariete, il pianeta Giove si trova in congiunzione col rosso anello del terribile Saturno. Lo spirito particolare dei cieli, se non m’inganno di molto, manifestava la sua potenza non soltanto sul globo fisico della terra, ma ben anche sulle anime, sui pensieri, sulle meditazioni dell’umanità.
Una notte, eravamo in sette, in fondo a un nobile palazzo in una triste città chiamata Tolemaide, seduti intorno ad alcune anfore d’un vino rosso di Chio. E la nostra camera non aveva altra entrata che un’alta porta di bronzo, e la porta era stata lavorata dall’artista Corinno, ed era d’una rara perfezione, e si chiudeva per di dentro. Del pari, dei panneggiamenti neri, proteggendo questa camera melanconica, ci risparmiavamo l’aspetto della luna, delle stelle lugubri e delle vie spopolate: – ma il presentimento e il ricordo del flagello non s’erano potuti così facilmente escludere. C’erano, intorno, presso a noi, delle cose di cui non posso render completamente ragione, – delle cose materiali e spirituali, – una pesantezza nell’atmosfera, – una sensazione di soffocamento, d’angoscia, – e, soprattutto quel terribile modo d’esistenza che subiscono le persone nervose, quando i sensi son crudelmente viventi e svegli, e le facoltà dello spirito assopite, intristite. Un peso mortale ci schiacciava. Si stendeva sulle nostre membra, – sul mobilio della sala, – sulle coppe in cui si beveva; e tutte le cose parevano oppresse, prostrate in quell’abbattimento, – tutto, eccetto le fiamme delle sette lampade di ferro che rischiaravano la nostra orgia. Allungandosi in minuti filamenti di luce, rimanevano tutte così, e bruciavano pallide e immobili; e nella rotonda tavola d’ebano, attorno a cui sedevamo, e che il loro chiarore trasformava in specchio, ogni convitato contemplava il pallore della sua propria faccia e il lampo inquieto degli occhi tristi dei suoi compagni. Nondimeno si mandavan delle risate, ed eravamo allegri a nostro modo, – un modo isterico; e si cantavano le canzoni d’ Anacreonte, – che non son che follia; e si beveva molto, quantunque la porpora del vino ci rammentasse la porpora del sangue. Perché c’era nella camera un ottavo personaggio, il giovane Zoilo.
Morto, lungo disteso e seppellito, egli era là il genio e il demone della scena. Ahimè! Non aveva parte, lui, al nostro divertimento; salvo che la sua faccia, sconvolta dal male, e gli occhi, dove la morte non avea spento che a mezzo il fuoco della peste, sembrava prendere tanto interesse alla nostra gioia quanto posson prendere i morti alla gioia di quelli che devon morire. Ma, benché io, Oinos, mi sentissi addosso, fissi su me, gli occhi del defunto, nondimeno mi sforzai di non comprendere l’amarezza della loro espressione, e, figgendo ostinatamente lo sguardo nelle profondità dello specchio d’ebano, cantai con voce alta e sonora le canzoni del poeta di Teo. Ma grado a grado il mio canto cessò, e gli echi, correndo lontano fra le nere drapperie della camera, divennero fievoli, indistinti, e svanirono. Ed ecco che dal fondo di quelle drapperie nere ove andava a morire il suono della canzone, s’arderse un’ombra, fosca, indefinita, – un’ombra simile a quella d’un corpo di un uomo, quando la luna è bassa nel cielo; ma non era l’ombra né d’un uomo, né di un Dio, né d’alcun altro essere comune. E quasi rabbrividendo, oscillando per un istante fra le drapperie, rimase infine visibile e dritta, sulla superficie della porta di bronzo. Ma l’ombra era vaga, senza forma, indefinita; non era l’ombra né di un uomo né di un Dio, – né di un Dio di Grecia, né d’un Dio di caldea, né d’alcun altro Dio egiziano. E l’ombra riposava sulla gran porta di bronzo e sulla cornice scolpita, e non si muoveva, e non pronunciava una parola: ma si fissava sempre più, e restò immobile. E la porta sulla quale l’ombra riposava era, se ben mi ricordo, proprio di contro ai piedi del morto Zoilo. Ma noi, i sette compagni, avendo veduto l’ombra mentre usciva dalle drapperie, non osavamo contemplarla fissamente, ma abbassavamo gli occhi, figgendoli sempre nelle profondità dello specchio d’ebano. E, finalmente, io, Oinos, ardii pronunziare alcune parole a bassa voce, e domandai all’ombra il suo nome e la sua dimora. E l’ombra rispose:
Io sono OMBRA, e la mia dimora è vicina alle catacombe di Tolemaide, e presso quelle cupe lande infernali, dove scorrono le acque impure di Caronte! –
E allora, tutti e sette, ci rizzammo inorriditi sui nostri seggi, e restammo così, tremanti, terrorizzati, convulsi; perché il timbro della voce dell’ombra non era quello d’un solo individuo, ma d’una moltitudine d’esseri; e quella voce, variando le sue inflessioni di sillaba in sillaba, veniva a caderci confusamente negli orecchi, imitando gli accenti noti e familiari di mille e mille amici scomparsi!

Edgar Allan Poe (1809-1849), è stato uno scrittore, poeta, critico letterario, giornalista, editore e saggista statunitense. E’ stato l’iniziatore del racconto poliziesco, della letteratura dell’orrore e del giallo psicologico, scrivendo anche storie di fantascienza e avventura.
L’audio è realizzato da Ménéstrandise Audiolibri (su Youtube)
Dicembre

aaaaaa
Il ponte
di Franz Kafka
Ero rigido e freddo; ero un ponte gettato sopra un abisso. Da questa parte erano conficcate le punte dei piedi, dall’altra le mani: avevo i denti piantati in un’argilla friabile. Le falde della mia giacca svolazzavano ai miei fianchi. Giù nel profondo rumoreggiava il gelido torrente dove guizzavano le trote. Nessun turista veniva a smarrirsi in quelle alture impervie, il ponte non era ancora segnato sulle carte. Così giacevo e aspettavo, dovevo aspettare. Una volta gettato, un ponte non può smettere di essere ponte senza precipitare. Un giorno verso sera – fosse la prima, fosse la millesima, non saprei dire – i miei pensieri erano un guazzabuglio, e facevano una ridda. Verso sera, d’estate, più cupo scrosciava il torrente, ecco che udii un passo umano! A me, a me! Stenditi, ponte, mettiti all’ordine, trave senza spalletta, sorreggi colui che ti è affidato. Compensa insensibilmente l’incertezza del suo passo, ma se poi vacilla, fatti conoscere e lancialo sulla terra come un Dio montano. Egli venne, mi percosse con la punta ferrata del suo bastone, poi sollevò le falde del mio abito e me le depose in ordine sul dorso. Infilò la punta del bastone nei miei capelli folti e ve la mantenne a lungo; probabilmente egli si guardava d’intorno con aria feroce. Poi a un tratto – io stavo appunto seguendolo trasognato per monti e valli – saltò a piedi giunti nel mezzo del mio corpo. Rabbrividii per l’atroce dolore, del tutto inconscio. Chi era? Un fanciullo? Un sogno? Un grassatore? Un suicida? Un tentatore? Un distruttore? E mi volsi per vederlo. Il ponte che si volta! Non ero ancora voltato e già precipitavo, precipitavo ed ero già dilaniato e infilzato dai ciottoli aguzzi che mi avevano sempre fissato così pacificamente attraverso l’acqua scrosciante”.

Franz Kafka (1883-1924) è stato uno scrittore boemo di lingua tedesca è ritenuto una delle maggiori figure della letteratura del XX secolo e importante esponente del modernismo, del surrealismo e del realismo magico.
Gennaio 2024

Il grasso ed il magro
di Anton Čechov
Alla stazione ferroviaria sulla linea San Pietroburgo-Mosca si incontrarono due amici: uno grasso e l’altro magro. Il grasso aveva appena pranzato alla stazione e le sue labbra, unte di burro, brillavano come una ciliegia matura. Mandava un odore di xeres e di fleur d’orange. Il magro era appena sceso dal vagone ed era carico di valigie, fagotti e scatole di cartone. Dietro la sua schiena sbirciavano una donna magrolina col mento lungo – sua moglie – e un ginnasiale spilungone con un leucoma in un occhio – suo figlio. Mandava un odore di prosciutto e fondi di caffè.
– Porfirij! – esclamò il grasso, vedendo il magro. – Sei proprio tu? Mio carissimo! Da quanto tempo non ci si vede!
– Santi del paradiso! – fece il magro spalancando la bocca. – Miša! Il mio amico d’infanzia! Da dove salti fuori?
Gli amici si abbracciarono tre volte e si fissarono l’un l’altro negli occhi pieni di lacrime. Erano entrambi piacevolmente sbalorditi.
– Mio caro! – cominciò il magro dopo gli abbracci. – Non me l’aspettavo proprio! Questa sì ch’è una sorpresa! Be’, guardami un po’ per benino! Vedi: sono sempre bello come una volta! Sempre ugualmente profumato e elegante! Ah, Dio mio! E tu, cosa fai? Sei ricco? Sei sposato? Io sono già sposato, come vedi… Ecco, questa è mia moglie Luisa, nata Vancenbach… luterana… E questo è mio figlio Nafanail, alunno della terza classe. Vedi, Nafanajlocka, questo è un mio amico d’infanzia! Al ginnasio abbiamo studiato insieme!
Nafanail ci pensò un po’ su e si levò il berretto.
– Al ginnasio abbiamo studiato insieme! – continuò il magro. – Ti ricordi che bel soprannome ti avevano dato? Ha, ha… Ti chiamavano Erostrato perché avevi bruciato con la sigaretta il registro scolastico; e me, mi chiamavano Efialte perché mi piaceva far la spia. Ah, ah!… Eravamo proprio dei bambini! Non aver paura Nafanajlocka! Avvicinati pure a lui… Questa è mia moglie, nata Vancenbach… luterana.
Nafanail ci pensò un po’ su e si nascose dietro la schiena del padre.
– Be’, come te la passi, amico? – domandò il grasso, guardando estasiato l’amico. – Sei impiegato? Hai fatto carriera?
– Sono impiegato, mio caro! Già da due anni sono assessore di collegio e ho la croce di San Stanislao! Lo stipendio è misero… be’, sia fatta la volontà di Dio! Mia moglie dà lezioni di musica, io nella vita privata faccio dei portasigari di legno. Dei portasigari fantastici! Li vendo a un rublo l’uno. Se qualcuno ne compra dieci o più, s’intende, gli faccio uno sconto… In qualche modo tiriamo avanti. Sono stato impiegato al Dipartimento «Presentazioni e refusi», ma adesso mi hanno trasferito qui come segretario nello stesso Ministero… Lavorerò qui. Il capufficio, a quanto dicono, è un porco; be’, che vada al diavolo! Sopravviverò in qualche modo. Ha lo stesso tuo cognome. Be’, e di te che mi dici? Mi immagino, sarai già consigliere di stato? Eh?
– Ve’ un po’… Così dunque sei tu il segretario che mi hanno destinato? – disse con voce profonda il grasso, gonfiandosi come un tacchino. – Vi presentate al lavoro in ritardo, egregio signore… Sì, in ritardo…
– Vv..voi? Siete voi?… Io, vostra eccellenza…
Il magro all’improvviso impallidì, ma ben presto il suo volto si torse da tutte le parti nel più ampio dei sorrisi… Lui si contrasse, si ingobbì, si rimpicciolì… Le sue valigie, i suoi fagotti e le sue scatole si contrassero e si rattrappirono… Il lungo mento della moglie divenne ancora più lungo; Nafanail si mise sull’attenti e, per un riflesso istintivo, si abbottonò tutti i bottoni della divisa…
– Io, vostra eccellenza… Molto piacere! Era, si può dire, un amico d’infanzia e adesso è un tale magnate! Hi! hi!
– Non si deve tardare, signor mio…
– Scusatemi tanto, vostra eccellenza, non ho potuto fare in tempo, perché mia moglie, ecco, era malata… Luisa, ecco… luterana…
– Spero, egregio signore, – disse il grasso porgendo la mano al magro – spero… Addio. Domani vi prego di presentarvi al lavoro…
Il magro gli strinse tre dita, si inchinò con tutto il torso e si mise a ridacchiare. Sua moglie sorrise… Nafanail strisciò un piede per inchinarsi e lasciò cadere il berretto. Tutti e tre erano piacevolmente sbalorditi.

Anton Pavlovič Čechov (1860-1904) è stato uno scrittore e drammaturgo russo, tra i maggiori autori letterari e teatrali europei del XIX secolo.
L’audio è realizzato da Baker Street Audiolibri (su Youtube)
Immagine di wirestock</a> su Freepik
Febbraio 2024

Arrenditi!
di Franz Kafka
Era molto presto di mattina, le strade pulite e vuote, andavo alla stazione. Quando confrontai l’orologio della torre con il mio, vidi che era già molto più tardi di quanto credessi, dovevo accelerare molto il passo, il terrore/sconcerto per questa scoperta mi fece diventare insicuro sulla strada da fare, non ero ancora molto pratico di questa città, per fortuna c’era un vigile nelle vicinanze, corsi da lui e senza fiato gli chiesi la strada. Lui rise e disse: «Da me tu vuoi sapere la strada?». «Sì – dissi io – perché da solo non so trovarla.» «Arrenditi, arrenditi» disse lui e si girò con grande slancio, come fa la gente che vuole essere sola con la sua risata.

Franz Kafka (1883-1924) è stato uno scrittore boemo di lingua tedesca è ritenuto una delle maggiori figure della letteratura del XX secolo e importante esponente del modernismo, del surrealismo e del realismo magico.
Marzo 2024

Lunedì o martedì
di Virginia Woolf
Pigro e indifferente, nello scuotere disinvolto lo spazio dalle sue ali, sicuro del suo andare, l’airone passa sopra la chiesa, sotto al cielo.
Bianco e distante, assorto in sé stesso, copre e scopre incessante il cielo, si sposta e rimane. Un lago? Cancella le sue rive! Una montagna? Oh, perfetto – il sole dorato sui suoi pendii. Dietro questa si eclissa. E poi felci, o piume bianche, per sempre, per sempre –
Desiderare la verità, attenderla, laboriosamente distillare poche parole, per sempre desiderare – (un grido si leva da sinistra, un altro da destra. Ruote stridono divergenti. Conglomerati di Omnibus in conflitto) – desiderare per sempre – (l’orologio assevera con dodici rintocchi che è mezzogiorno; la luce emana lame dorate; bambini sciamano) – per sempre desiderare la verità.
Rossa è la volta; monete pendono dagli alberi; il fumo si trascina su per i camini; latrati, urla, il grido “Ferro da vendere” – e la verità?
Irraggiati in un punto, piedi di uomo e di donna, incrostati di nero o d’oro – (Questo tempo nebbioso – Zucchero? No, grazie – Il Commonwealth del futuro) – il caminetto lancia dardi di luce e arrossa la stanza, ma non le figure scure e i loro occhi lucenti, mentre fuori un autocarro scarica, Miss Vattelapesca beve il tè al suo tavolo, e la vetrina preserva cappotti di pelliccia –
Ostentata, leggera come una foglia, accumulata negli angoli, soffiata tra le ruote, schizzata d’argento, a casa o non a casa, raccolta, sparpagliata, frantumata in singole scaglie, spazzata su, giù, strappata, affondata, composta – e la verità?
Ora accanto al fuoco ricordare sul bianco riquadro di marmo. Da profondità d’avorio parole in crescendo diffondono la loro nerezza, sbocciano e penetrano. Caduto il libro;
nella fiamma, nel fumo, nelle scintille fugaci – o viaggiando ora, il quadrato di marmo a pendere, minareti al di sotto e mari dell’India, mentre lo spazio corre azzurro e le stelle splendono – la verità? Contentezza della vicinanza?
Pigro e indifferente l’airone ritorna; il cielo vela le sue stelle; poi le scopre.

Adeline Virginia Woolf (1882–1941), è stata una scrittrice, saggista e attivista britannica. Considerata come una delle principali figure della letteratura del XX secolo, attivamente impegnata nella lotta per la parità di diritti tra i sessi.
Aprile 2024

Il vecchio nonno ed il nipotino
di Lev Tolstòj
Il nonno era molto vecchio. Le gambe non lo portavano più, i suoi occhi non vedevano, le sue orecchie non udivano, egli non aveva più denti e quando mangiava faceva la bava.
Il figlio e la nuora cessarono di fargli posto a tavola e lo mandarono a mangiare dietro la stufa.
Un giorno gli fu portato il cibo in una scodella. Tentando di muoverla, egli la lasciò cadere e la scodella si ruppe. La nuora cominciò a insultare il vecchio, rimproverandogli di guastare tutto nella casa, di rovinare le stoviglie e dichiarò che da allora in poi gli avrebbe dato da mangiare in una ciotola di legno.
Il vecchio sospirò, senza dire nulla.
Un giorno che il contadino e sua moglie erano rimasti in casa videro il loro bambino divertirsi, per terra, con dei pezzi di legno che cercava di mettere insieme. Il padre gli disse:
«Che stai facendo, Michele?».
Michele rispose: «Fabbrico una ciotola. Quando tu e la mamma sarete vecchi, mi servirà per darvi da mangiare».
Il contadino e sua moglie si guardarono e scoppiarono in lagrime. Ebbero vergogna del loro comportamento verso il vecchio: da quel giorno gli ridiedero un posto a tavola e lo circondarono di cure.

Lev Nikolàevič Tolstòj, in italiano anche noto come Leone Tolstoi (1828-1910) è stato uno scrittore, filosofo, educatore e attivista sociale russo.
Immagine di Harryarts su Freepik</a>
Maggio 2024

Verde Azzurro
di Virginia Woolf
VERDE
Le acuminate dita di vetro pendono dall’alto. La luce scivola giù lungo il vetro e goccia una pozza di verde. Per tutto il giorno le dieci dita del lampadario sgocciolano il verde sul marmo. Le piume dei parrocchetti – le loro lamentose strida – le foglie aguzze delle palme – verdi anch’esse; verdi aghi che scintillano al sole. Ma il duro vetro continua a sgocciolare sul marmo; le pozze si librano sopra la sabbia del deserto; i cammelli vi si acquattano; le pozze si posano sul marmo; i giunchi le orlano; le alghe li intarsiano; qua e là un fiore bianco; la rana fa un balzo; di notte le stelle appaiono intatte. Viene la sera e l’ombra spazza via il verde sulla cappa del camino; la superficie increspata dell’oceano. Non arrivano navi; le onde senza scopo si agitano sotto il cielo vuoto. È notte; gli aghi sgocciolano chiazze d’azzurro. Il verde è svanito.
AZZURRO
Il mostro dal naso camuso affiora in superficie e spruzza dalle narici schiacciate due colonne d’acqua, di un bianco lucente al centro, che si sprizzano in una frangia di perline azzurre. Pennellate di azzurro rigano l’incerata nera del suo manto. Spruzzando acqua da bocca e narici, s’inabissa, carico d’acqua, e l’azzurro si richiude su di lui, inghiottendo i ciottoli lustri dei suoi occhi. Prostrato, gettato sulla spiaggia, vi si accascia, ottuso, perdendo aride scaglie azzurre. La loro tinta metallica macula il ferro arrugginito sulla spiaggia. Azzurre sono le costole della barca a remi naufragata. Un’onda rotola sotto le campane blu azzurre. Ma la cattedrale è differente, fredda, gravata di incenso, azzurro tenue dai veli delle madonne.

Adeline Virginia Woolf (1882–1941), è stata una scrittrice, saggista e attivista britannica. Considerata come una delle principali figure della letteratura del XX secolo, attivamente impegnata nella lotta per la parità di diritti tra i sessi.
Immagine di freepik</a>
Giugno 2024

La risposta
di Fredric William Brown
Con gesti lenti e solenni Dwar Ev procedette alla saldatura, in oro, degli ultimi due fili. Gli occhi di venti telecamere erano fissi su di lui e le onde subteriche portarono da un angolo all’altro dell’universo venti diverse immagini della cerimonia.
Si rialzò con un cenno del capo a Dwar Reyn, e s’accostò alla leva dell’interruttore generale: la leva che avrebbe collegato, in un colpo solo, tutti i giganteschi calcolatori elettronici di tutti i pianeti abitati dell’Universo – 96 miliardi di pianeti abitati – formando il super circuito da cui sarebbe uscito il supercalcolatore, un’unica macchina cibernetica racchiudente tutto il sapere di tutte le galassie.
Dwar Reyn rivolse un breve discorso agli innumerevoli miliardi di spettatori. Poi, dopo un attimo di silenzio disse: “Tutto è pronto Dwar Ez”. Dwar Ez abbassò la leva. Si udì un formidabile ronzio che concentrava tutta la potenza, l’energia di novantasei miliardi di pianeti. Grappoli di luci multicolori lampeggiarono sull’immenso quadro, poi, una dopo l’altra si attenuarono. Draw Ez fece un passo indietro e trasse un profondo respiro. “L’onore di porre la prima domanda spetta a te, Dwar Reyn”. “Grazie” rispose Dwar Reyn “Sarà una domanda cui nessuna macchina cibernetica ha potuto, da sola, rispondere”. Tornò a voltarsi verso la macchina. “C’è Dio?”. L’immensa voce rispose senza esitazione, senza il minimo crepitio di valvole o condensatori.
“Sì: adesso, Dio c’è.”
Il terrore sconvolse la faccia di Dwar Ev, che si slanciò verso il quadro di comando.
Un fulmine sceso dal cielo senza nubi lo incenerì, e fuse la leva inchiodandola per sempre al suo posto.

Fredric William Brown (1906 – 1972) è stato uno scrittore statunitense di fantascienza e di gialli.
Immagine di freepik</a>
Luglio 2024

Il gatto sotto la pioggia
di Ernest Miller Hemingway
C’erano solo due americani alloggiati in quell’albergo. Non conoscevano nessuna delle persone che incontravano per le scale quando andavano e venivano dalla loro stanza. La loro stanza era al primo piano e dava sul mare. Dava anche sul giardino pubblico e sul monumento ai caduti. Nel giardino pubblico c’erano grandi palme e panchine verdi. Col tempo bello c’era sempre un pittore col suo cavalletto.
Ai pittori piaceva come crescevano le palme, e i vivaci colori degli alberghi affacciati sul giardino pubblico e sul mare. Gli italiani venivano da lontano a vedere il monumento ai caduti, che era di bronzo e luccicava sotto la pioggia. Pioveva. La pioggia gocciolava dai palmizi. L’acqua stagnava nelle pozzanghere sulla ghiaia dei sentieri. Il mare si rompeva in una lunga riga sotto la pioggia e scivolava sul piano inclinato della spiaggia per tornare su a rompersi di nuovo in una lunga riga sotto la pioggia.
Le macchine erano sparite dalla piazza vicino al monumento. Oltre la piazza, sulla soglia del caffè, un cameriere stava guardando fuori verso la piazza deserta. La moglie americana stava guardando fuori dalla finestra. Fuori, proprio sotto la finestra, un gatto era accucciato sotto uno dei tavoli verdi gocciolanti. Il gatto cercava di raggomitolarsi su se stesso per non farsi bagnare dalle gocce. «Vado giù a prendere quel micino» disse la moglie americana.
«Ci vado io» propose dal letto suo marito. «No, vado io. Quel povero micino si è nascosto sotto un tavolo per non bagnarsi.» Il marito continuò a leggere, disteso ai piedi del letto con la testa appoggiata ai due cuscini. «Non bagnarti» disse. La moglie scese al pianterreno e il proprietario dell’albergo le fece un inchino mentre passava davanti all’ufficio. Il suo scrittoio era in fondo alla stanza. Era un uomo anziano e molto alto. «Piove» disse l’americana. Le era simpatico, quell’albergatore.
«Sì, sì, signora, brutto tempo. Il tempo è molto brutto.» Era ritto dietro il suo scrittoio in fondo alla stanza semibuia. L’americana lo trovava simpatico. Le piaceva la tremenda serietà con cui accoglieva i reclami. Le piaceva la sua dignità. Le piaceva il desiderio che mostrava di servirla. Le piaceva la considerazione che aveva per il proprio mestiere. Le piacevano la sua faccia, vecchia e pesante, e le sue mani. Sempre pensando che quell’uomo le piaceva, aprì la porta e guardò fuori. Si era messo a piovere più forte.
Un uomo con un mantello di gomma stava attraversando la piazza deserta nella direzione del caffè. Il gatto doveva essere sulla destra. L’americana pensò che forse poteva procedere sotto le grondaie. Mentre stava sulla soglia un ombrello si aprì dietro di lei. Era la cameriera addetta alla loro stanza. «Non deve bagnarsi» sorrise, parlando in italiano. Naturalmente, l’aveva mandata l’albergatore. Con la cameriera che le teneva l’ombrello sopra la testa, camminò sulla ghiaia del sentiero finché non fu sotto la finestra.
C’era il tavolo, di un verde ravvivato dalla pioggia, ma il gatto era sparito. L’americana fu presa da un inaspettato disappunto. La cameriera alzò lo sguardo a lei. «Ha perduto qualcosa, signora?» «C’era un gatto» disse l’americana. «Un gatto?» «Sì, un gatto.» «Un gatto?» rise la cameriera. «Un gatto sotto la pioggia?» «Sì» disse lei «sotto il tavolo.» Poi: «Oh, lo desideravo tanto. Volevo un micino». Quando parlò in inglese la fronte della cameriera si accigliò. «Venga, signora» disse. «Dobbiamo rientrare. Si bagnerà.» «Credo anch’io» disse l’americana.
Tornarono indietro sulla ghiaia del sentiero e varcarono la soglia. La cameriera restò fuori a chiudere l’ombrello. Mentre l’americana passava davanti all’ufficio, il padrone dallo scrittoio le fece un inchino. La ragazza si sentiva, dentro, qualcosa di molto piccolo e duro. Il padrone la faceva sentire molto piccola e davvero importante al tempo stesso. L’americana ebbe la sensazione passeggera di essere una persona straordinariamente importante. Salì le scale. Aprì la porta della stanza. George era sdraiato sul letto e leggeva.
«Hai trovato il gatto?» chiese, posando il libro. «È sparito.» «Chissà dov’è andato» disse lui, riposandosi gli occhi dalla lettura. Lei si sedette sul letto. «Lo desideravo tanto» disse. «Non so perché lo desideravo tanto. Volevo quel povero micino. Non è affatto divertente essere un povero micino fuori sotto la pioggia.» George si era rimesso a leggere. Lei andò a sedersi davanti allo specchio della toeletta e si guardò con lo specchio da viaggio. Studiò il suo profilo, prima da una parte e poi dall’altra. Poi si esaminò la nuca e il collo.
«Non credi che sarebbe una buona idea se mi lasciassi crescere i capelli?» chiese, guardando nuovamente il suo profilo. George alzò gli occhi e vide la sua nuca, con i capelli corti come quelli di un ragazzo. «A me piacciono così come sono.» «Sono stufa» disse lei. «Sono stufa di sembrare un ragazzo.» George, sul letto, cambiò posizione. Non aveva distolto lo sguardo da sua moglie da quando lei si era messa a parlare. «Sei maledettamente bella» disse. Depose specchio sulla toeletta e andò alla finestra e guardò fuori. Stava facendosi buio.
«Voglio pettinarmi con i capelli all’indietro, lisci e ben tirati, e farmi sulla nuca un bel nodo grosso e pesante» disse lei. «Voglio avere un gatto da tenere sulle ginocchia, e che faccia le fusa quando lo accarezzo.» «Sì?» disse George dal letto. «E voglio mangiare: a tavola con la mia argenteria e voglio delle candele. E voglio che sia primavera e voglio spazzolarmi i capelli davanti, allo specchio e voglio un gattino e voglio dei vestiti nuovi.» «Oh, smettila e cercati qualcosa da leggere» disse George. Aveva ripreso la lettura. Sua moglie guardava fuori dalla finestra.
Ormai era buio pesto e sulle palme continuava a piovere. «Comunque, voglio un gatto» disse lei «voglio un gatto. Voglio subito un gatto. Se non posso avere i capelli lunghi o se non posso divertirmi, posso almeno avere un gatto.» George non ascoltava. Stava leggendo il suo libro. Sua moglie guardò la piazza, fuori dalla finestra, dove si erano accese le luci. Qualcuno bussò alla porta. «Avanti» disse George. Alzò gli occhi dal libro. Sulla soglia c’era la cameriera. Teneva in braccio, stringendoselo al petto, un gattone color tartaruga, con le zampe posteriori penzoloni. «Mi scusi» disse «il padrone mi ha ordinato di portare questo alla signora.»

Ernest Miller Hemingway (1899-1961) è stato uno scrittore e giornalista statunitense. Fu autore di romanzi e racconti.
Immagine di freepik</a>